ANDREA MINGARDI, il ritorno al canto jazz

Il poliedrico cantante e bluesman bolognese parla della sua fortunata carriera, del suo ultimo album (Ho visto cose che…) e di Bologna che lo ha premiato come jazzman. Nell’intervista pubblicata su Musica Jazz online scoprirete che Andrea Mingardi iniziò la carriera artistica come batterista-cantante di rock’n ‘roll, poi di jazz, la musica che ha ascoltato e studiato con passione sconfinata fin da bambino e che offrì una bella sponda solidale a jazzisti di fama mondiale come il sassofonista argentino Gato Barbieri e il pianista canadese Paul Bley.
Iniziò sessant’anni fa creando il primo gruppo italiano di rock’n’roll! E dopo una breve stagione jazzistica intraprese il ruolo di messaggero del divertimento e della gioia di vivere con i ritmi ballabili riscuotendo successi incredibili di pubblico in tutte le grandi balere italiane. Una storia musicale che non è ancora finita, e nonostante le ottanta primavere alle spalle. Infatti, recentemente il soul-bluesman bolognese ha ingranato una nuova marcia con il progetto «E Allora Jazz…» cantando i migliori successi di Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Tony Bennet. E contemporaneamente e sorprendentemente la comunità jazzistica bolognese gli ha conferito il Premio Strada del Jazz 2019. Stiamo parlando di Andrea Mingardi, cantante, compositore, bandleader, pittore, scrittore, ex-calciatore e membro della Nazionale cantanti.
 Mingardi non è solo un grande showman, ma è anche un uomo divertente, goliardico al punto giusto, un umorista dalla battuta facile e impareggiabile nel bolognesizzare testi di canzoni pop, rock, funky e blues con la voce roca e nera tipica del Delta del Mississippi, ma lui è un petroniano doc. Come cantautore vanta collaborazioni con Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Josè Feliciano e ha girato il mondo con i Blues Brothers.
Mingardi non è solo un grande showman, ma è anche un uomo divertente, goliardico al punto giusto, un umorista dalla battuta facile e impareggiabile nel bolognesizzare testi di canzoni pop, rock, funky e blues con la voce roca e nera tipica del Delta del Mississippi, ma lui è un petroniano doc. Come cantautore vanta collaborazioni con Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Josè Feliciano e ha girato il mondo con i Blues Brothers.
A metà degli anni Sessanta come cantante e leader di un’orchestra da ballo si impone come una delle principali attrazioni delle balere italiane con un patchwork di sonorità e tendenze musicali diverse, quelle in cui ciascuno ascoltatore o spettatore (e spesso eravamo in tantissimi, anche tremila persone!) trovava un po’ della musica che preferiva ma al di fuori di quel sentimentalismo e melodramma che aveva plasmato le generazioni precedenti. Un mix con tutte le canzoni e le musiche moderne che conquistarono il mondo intero dagli anni Cinquanta in poi aggiungendovi anche brani di sua composizione. Infatti sono pochissimi i grandi successi internazionali che Andrea Mingardi non ha cantato nel corso della sua strepitosa carriera. Ha interpretato tutti: da Elvis Presley ai Beatles, da Chuck Berry a Joe Cocker, da Little Richard ai Rolling Stones, dagli Animals a Wilson Pickett, dai Pink Floyd a Otis Redding, Beach Boys, Led Zeppelin, Deep Purple, James Brown, Chicago, Blood Sweat & Tears, Jethro Tull, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival, Frank Zappa, Police e altri. Il suo primo 45 giri risale al 1962, mentre il cd più recente, «Ho visto cose che…», è uscito nel 2018 (Incipit Records, distr. Egea Music).
Se per il grande pubblico è stato ed è il più celebre intrattenitore emiliano romagnolo dei dancing, per tanti orchestrali degli anni Settanta Andrea era un punto di riferimento, grazie anche ai validissimi musicisti delle sue band.
Se il grande pubblico sa che il cantautore bolognese ha partecipato più volte al festival di Sanremo e vanta collaborazioni con grandi artisti italiani come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Stadio e un duetto con Mina, pochi invece sanno che Andrea iniziò come batterista-cantante di rock ‘roll, poi di jazz, la musica che ha ascoltato e studiato con passione sconfinata fin da bambino e oggi afferma di essere «L’unico cantante italiano in circolazione che conosce tutti gli standard della jazz song americana, ma anche le pagine immortali della bossa nova e del samba jazz. Perché è vero che ho un’anima soul e un cuore blues, ma se vuoi – continua Andrea – ti ubriaco anche con João Gilberto, Tom Jobim, Chico Buarque, Sergio Mendes, Corcovado, Desafinado, The Girl From Ipanema, Chega de Saudade, Tristeza. Aquarela do Brasil eccetera. Li conosco tutti e Giancarlo Gualdi, pianista e fratello di Henghel, lo può testimoniare». In attesa di un’eventuale sana ubriacatura carioca siamo andati alla scoperta del lungo filo rosso che ha riportato Mingardi al Great American Songbook. Ecco il botta e risposta, abbastanza movimentato per la verità, poiché il nostro versatile interlocutore spazia in modo trasversale tra stili musicali, cita con ironia aneddoti che hanno segnato il suo cammino e si rischia così di perdere quel filo rosso che unisce varie fasi e lunghi anni di attività.
Andrea, chi, per ragioni anagrafiche o di gusti musicali, non ha seguito fin dagli inizi gli sviluppi della tua maratona artistica, oggi alla luce dei recenti progetti potrebbe domandarti cosa ti è successo. E invece io che da lontano ti ho tenuto d’occhio utilizzo il tuo “idioma” per chiederti di togliermi «il dubito»: non hai mai avuto l’impressione o il dubbio di aver sbagliato strada? Hai ottenuto esattamente quello che immaginavi in gioventù?
Prima di tutto sono contento che tu abbia hai ascoltato Anima Soul (dal mio ultimo disco «Ho visto cose che…», Incipit Records, 2018): in una battuta veloce ci tengo a dire che in qualche modo lo spirito jazz è sempre passato vicino alle mie musiche e alla mia maniera di suonare ma…
 Ma…., e scusami se ti interrompo, nel disco citato a mio avviso il jazz fa capolino soltanto con il soprano di Stefano Di Battista in Riaprono i locali , mentre molti degli altri brani sono elaborati in chiave soul, blues, funk e rock, ossia quegli stili che hanno contraddistinto grandissima parte della tua lunga carriera. Detto questo, jazz o no, é un disco di musica trascinante, contagiosa, divertente e con un’enorme carica ritmica. E allo stesso tempo alcuni testi invitano a riflettere sulla vita odierna, sul caos politico-sociale. Insomma, una sorta di messaggio-sveglia ai giovani, contro l’individualismo eccetera, è giusto?
Ma…., e scusami se ti interrompo, nel disco citato a mio avviso il jazz fa capolino soltanto con il soprano di Stefano Di Battista in Riaprono i locali , mentre molti degli altri brani sono elaborati in chiave soul, blues, funk e rock, ossia quegli stili che hanno contraddistinto grandissima parte della tua lunga carriera. Detto questo, jazz o no, é un disco di musica trascinante, contagiosa, divertente e con un’enorme carica ritmica. E allo stesso tempo alcuni testi invitano a riflettere sulla vita odierna, sul caos politico-sociale. Insomma, una sorta di messaggio-sveglia ai giovani, contro l’individualismo eccetera, è giusto?
Se la metti così va molto bene, però vorrei partire da più lontano per illustrare meglio la mia storia. Essendo un figlio del dopoguerra (sono nato nel 1940) l’unica possibilità di allora per andare oltre i cantanti melodici italiani – cioè quelli accompagnati dalle orchestre di Angelini, Barzizza, Semprini eccetera – era quella di ascoltare la musica che arrivava dagli Stati Uniti. Si trattava di una ventata di aria fresca, dopo un ventennio di autarchia dove non si poteva cantare roba americana, e di questa censura ne sapevano qualcosa Ernesto Bonino, Alberto Rabagliati e Natalino Otto ai quali si impediva di cantare in inglese, senza parlare poi delle ridicole traduzioni in italiano di alcune canzoni come Tristezza di San Luigi (St.Louis Blues), Il ruggito della tigre (Tiger Rag), hai capito come andavano le cose? A metà degli anni Cinquanta per noi appassionati si presentò poi la possibilità di scoprire il rock’n’roll, musica vivace, trasgressiva che sconvolse poi tutte le nuove generazioni. Ma ancor prima di questa ondata musicale, e grazie alla bella collezione di dischi d’oltreoceano di mio zio, io mi ero già innamorato del jazz, tuttavia ero onnivoro e attento anche alle altre novità.
Come definiresti il jazz?
Intanto che non è musica e basta, perché il jazz è voglia di raccontare, di coinvolgere, è il frutto di incontri, è musica che interpreta il passato, il presente e il futuro, è dialogo tra il gruppo e il solista, è improvvisazione. Ma prima ancora direi che il jazz è un modo di essere, la cui anima è azionata dallo swing e se non ce l’hai…
 Quando hai capito che il jazz era la tua musica?
Quando hai capito che il jazz era la tua musica?
Io ho cominciato a capire qualcosina di quel sound che mi emozionava così tanto nel primo dopoguerra con i 78 giri di mio zio, dischi che mi affascinavano e mi hanno illuminato la mente. Quello credo che sia stato l’imprinting in quanto nei programmi della radio era difficile sentire le orchestre di Harry James, Benny Goodman e Frank Sinatra-Così tutte le canzoni di quei grandi artisti le ho assimilate e imparate ascoltando quei dischi. E uno che mi colpì fu un lavoro di un jazzman importante come Mel Tormé.
Si vede che eri predestinato, ed è toccato a Tormé, che per l’appunto era cantante e batterista, a stimolarti per scegliere quei percorsi. Infatti per quanto mi è dato sapere ti sei avvicinato alla musica proprio sui tamburi, è giusto?
Sì! Ed è nato così: mio padre accompagnava con coltello e forchetta le canzoni che uscivano dalla radio e quindi per imitazione da bambino cominciai a ritmare su tavola, sedie e panche di legno imparando presto la differenza tra il battere e il levare.
Ti ricordi la marca della tua prima batteria e il primo maestro che ti ha dato le dritte per impugnare correttamente le bacchette e a scoprire i segreti dello strumento?
Ho iniziato quando avevo dodici o tredici anni con la mia prima batteria che era una Super Alberti. Per quanto riguarda paradiddles, rudimenti fondamentali eccetera che si conoscevano in quel periodo ho imparato tutto da solo, da autodidatta.
Con quale gruppo è avvenuto il tuo esordio sul palcoscenico?
 Si chiamava Golden Rock Boys e siamo stati il primo gruppo italiano in assoluto di rock’n’roll, insomma degli antesignani nel Belpaese di questo genere che rivoluzionò la musica moderna. Eravamo alla fine degli anni Cinquanta quando iniziai la mia carriera musicale come cantante-batterista interpretando Tutti i frutti , Be Bop A Lula, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, Lucille, Love Me Tender eccetera. E proprio in quel periodo, durante una serata dalle parti di Modena, mi presentarono una ragazza che cantava con il nome di Baby Gate: era Mina, con la quale ci scambiammo il numero di telefono e da quel momento rimanemmo in contatto, ci si sentiva spesso e alla fine mi chiese di collaborare ad alcuni suoi progetti.
Si chiamava Golden Rock Boys e siamo stati il primo gruppo italiano in assoluto di rock’n’roll, insomma degli antesignani nel Belpaese di questo genere che rivoluzionò la musica moderna. Eravamo alla fine degli anni Cinquanta quando iniziai la mia carriera musicale come cantante-batterista interpretando Tutti i frutti , Be Bop A Lula, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, Lucille, Love Me Tender eccetera. E proprio in quel periodo, durante una serata dalle parti di Modena, mi presentarono una ragazza che cantava con il nome di Baby Gate: era Mina, con la quale ci scambiammo il numero di telefono e da quel momento rimanemmo in contatto, ci si sentiva spesso e alla fine mi chiese di collaborare ad alcuni suoi progetti.
Continua il racconto dei Golden Rock Boys.
Cantavamo i successi dei protagonisti americani di quel periodo: Gene Vincent, Elvis Presley, Little Richard e Chuck Berry, artista quest’ultimo che adorava il blues e influenzò nel tempo Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones e tantissimi altri. Tutto questo andò avanti fino all’invasione dei Beatles, Rolling Stones, Animals eccetera. Mentre suonavo rock’n’roll, assieme a un mio compagno di scuola, di nome Zanarini, sassofonista tenore, cercavamo però di tirare giù dei pezzi di jazz, in particolare «Paris Concert» del 1954 del quartetto di Gerry Mulligan, un musicista che ci aveva fulminati tutti. Ero ancora acerbo con la batteria e pensa che per ottenere un certo fruscio, come fosse un rullante, suonavo con le spazzole su un giornale appoggiato su una sedia. E addirittura ci registravamo le prove con un Geloso! Insomma ero ancora abbastanza ignorante di jazz ma avevo una grande volontà di fare, quella volontà che poi mi permise di cantare e suonare con la Rheno Jazz Gang agli inizi del Sessanta, credo 1961, e di debuttare poi discograficamente con il mio primo 45 giri: nel lato B cantavo No Girls For Me To Night mentre il lato A si chiamava Ballata di un tromba (un successo di Nini Rosso) e nella band c’erano tra gli altri Pupi Avati (cl.), Checcho Coniglio (trne), Antonio Corsello (p.) e Franco Tolomei (tr). Ancora prima di quel 45 giri avevo inciso Lentement dans la nuit/Si je pouvais, per una ragazza francese, ma niente di importante.
Mi risulta che hai fatto parte anche nella jazz band reggiana di Vanni Catellani, trombettista, che tra l’altro nel 1968 al festival di Sanremo fu protagonista sul palco con Louis Armstrong: è giusto?
Giustissimo. Cantavo con l’orchestra di Vanni Catellani, tra l’altro un trombettista fantastico, e mi faceva interpretare tutti gli standard americani ed eravamo sempre nella prima metà degli anni Sessanta.
 E quando hai capito che era più redditizio e soddisfacente fare il cantante solista che il batterista di rock’n’roll o di jazz?
E quando hai capito che era più redditizio e soddisfacente fare il cantante solista che il batterista di rock’n’roll o di jazz?
L’arrivo di quei ragazzetti britannici in giacchettine e capelli a caschetto, i Beatles, decretò la scomparsa delle star del rock’n’roll come Elvis Presley, Chuck Berry e di tutto quel mondo sonoro che ci girava attorno. A quel punto dovetti stabilire se affrontare la musica con canzoni a trecentosessanta gradi, Beatles, Rolling Stones, Animals eccetera o rimanere un nostalgico aggrappato a Elvis. Poi ascoltando suggerimenti di Catellani, Piergiorio Farina, Paolo Zavallone e di Henghel Gualdi cominciai a guardarmi intorno e sono diventato un cantante frontman.
E così sono finite nel sottoscala anche le tue aspirazioni jazzistiche?
Non proprio, ma mi sono adattato alla situazione. Tuttavia non bisogna dimenticare che per tutti gli orchestrali e per i musicisti moderni la stella polare è sempre stato il jazz, perlomeno fino a Woodstock. Pertanto come orchestrale ti salvavi se conoscevi un po’ di brani jazzistici. Poi vivere a Bologna è stata una fortuna per un appassionato di jazz poiché per vent’anni Bologna è stata una capitale del jazz. Inoltre bastava spostarsi a Reggio Emilia dove all’inizio del Sessanta arrivarono anche lì dei grandi maestri del jazz. Questo per dirti che il jazz comunque era sempre con noi e anche se suonavi altra musica non potevi allontanarti del tutto perché una volta “infettato” dal virus del jazz non te lo toglie più nessuno. Ho comunque dei ricordi bellissimi di quel periodo: mi vanto di aver mangiato all’ex Continental (la tavola calda di fronte all’Arena del Sole di Bologna) i tortelloni con Miles Davis; ho cenato diverse volte con Chet Baker; ho parlato di jazz con i componenti del Modern Jazz Quartet. E tra tanti altri che non sto a citare, ho incrociato anche Gerry Mulligan e di cui ho avuto l’onore della scopertura della stella 2019 a lui dedicata nella Strada del Jazz, cioè via Orefici di Bologna.
 Prima di approfondire l’argomento jazz a Bologna, vorrei proseguire il discorso sulla tua carriera come leader della più importante orchestra di ritmi ballabili moderni di tutta l’Emilia Romagna e non solo. La prima volta che vidi la tua mitica band, con una sezione fiati di ottimi solisti, gente che sapeva articolare passaggi inequivocabilmente jazzistici, fu a cavallo tra il ’69 e il ’70 allo Sporting Club di Bologna. Da lì in poi notai che, come nessun altro, riuscivi a trascinare tantissimi estimatori in giro per tutta l’Emilia Romagna per assistere ai tuoi concerti-happening.
Prima di approfondire l’argomento jazz a Bologna, vorrei proseguire il discorso sulla tua carriera come leader della più importante orchestra di ritmi ballabili moderni di tutta l’Emilia Romagna e non solo. La prima volta che vidi la tua mitica band, con una sezione fiati di ottimi solisti, gente che sapeva articolare passaggi inequivocabilmente jazzistici, fu a cavallo tra il ’69 e il ’70 allo Sporting Club di Bologna. Da lì in poi notai che, come nessun altro, riuscivi a trascinare tantissimi estimatori in giro per tutta l’Emilia Romagna per assistere ai tuoi concerti-happening.
Mi fa molto piacere sentire rievocare quel periodo perché eravamo forse gli unici a suonare magistralmente tutti i brani in voga di r&b, soul, Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Rufus Thomas eccetera. Quindi per far ballare la gente bisognava spingere con dei fiati potenti come Lauro Molinari, Enzo Gilioli e Giuseppe Martini, dei quali si apprezzava una notevole tecnica di stampo jazzistico. E, per la cronaca, nell’ambiente orchestrale venivano considerati dei jazzisti quelli che sapevano improvvisare su un’armonia più complessa rispetto al giro armonico del blues.
Verissimo. Ma a un certo punto nacque una frattura nella band e i tuoi musicisti fondarono una nuova orchestra chiamata «49%». Di quel divorzio ne parlavano qua e là gli orchestrali ma senza capirne ragioni, visto che eravate affiatatissimi e i migliori sulla piazza. Finalmente puoi dirci i veri motivi di quella rottura?
Se ne sono andati loro con quel nome poiché io ero identificato come il 51% della band. Hanno suonato per un po’ di tempo poi hanno chiuso i battenti come del resto tanti altre orchestre con l’arrivo delle discoteche. Il motivo della separazione? Forse volevano avere il controllo della aspetto societario, cosa che succedeva anche in altre orchestre.
 E anche questo è vero, ma tutto ciò perché a livello sociale si respirava ovunque un desiderio di democraticizzazione in tutti i contesti, e la tensione politica influiva anche sui comportamenti dei musicisti.
E anche questo è vero, ma tutto ciò perché a livello sociale si respirava ovunque un desiderio di democraticizzazione in tutti i contesti, e la tensione politica influiva anche sui comportamenti dei musicisti.
Sono d’accordo, il clima era quello, comunque si sappia che quella scelta di andarsene non era dovuta a discussioni sulle capacità professionali ma sul come portare avanti il progetto. Ad ogni modo si rivelò una situazione antipatica, però la affrontai con tranquillità sapendo che tutto il mondo è paese, e non solo tra dei provinciali come eravamo noi. Dico questo pensando alla risposta di Miles Davis (che sembrava sempre incazzato!) quando gli chiesi cosa ne pensasse di Charlie Parker:«Uno stronzo!!!». Quindi capisci che uno spirito sano di competizione anche tra gli artisti c’è sempre stato, e continuerà. Io poi andai avanti mettendo in campo una nuova formazione, Supercircus, arruolando altri talentuosi strumentisti come Alan King, Enzo Feliciati. Leandro Gaetano, Giulio Capiozzo, Ares Tavolazzi, insomma gente che “spaccava” come direbbero i giovani di oggi.
Vuoi dire che tutti i mali non vengono per nuocere?
Indirettamente direi che è così, poiché con i Supercircus abbandonai il vecchio concetto dell’orchestra da ballo e cercai di impormi con cose diverse, spettacolari, che riscossero notevole successo: realizzai in mix molto curato di musica, rock, beat, twist, surf, Genesis, Chicago, ma anche poesie musicali e arrivando fino a Frank Zappa e tutto dentro una matrice allegra e teatrale.
Ma ancora prima di quella fortunatissima stagione del Settanta (di cui sono testimone) avevi maturato altre esperienze importanti tirando tardi in locali torinesi: è così? Ce ne parli?
Bravo, quella fu una stagione formidabile in mezzo a una sfavillante scena musicale e con momenti davvero divertenti nella mia vita. Di questo ne ho parlato nel libro pubblicato diversi anni fa con il titolo Permette un ballo, signorina?, che si tratta di un racconto di swing, di blues, di soul, dalla Bologna degli anni Sessanta fino a Torino, con le grandi balere sullo sfondo. Descrivo i locali notturni più in voga in quegli anni, aspetti di una certa vita allegra, il caffé al Valentino, di un albergo che è stato per me un riferimento, il Poncini gestito da un appassionato di jazz, Secondo Poncini, il quale possedeva una collezione di quasi cinquemila dischi dei più grandi jazzisti del mondo. Con questo signore passavamo ore a discutere su un’incisione di Miles Davis o su un concerto di Chet Baker. A Torino ho vissuto poi storie davvero incredibili, come questa: stavo suonando in un dancing con un’ottima orchestra e di cui faceva parte anche Eddie Busnello, che non so quante persone oggi sappiano chi era costui.
 Stai parlando del sassofonista, un po’ problematico, che suonò tra l’altro anche con il gruppo di Kenny Clarke e per un tempo cortissimo con gli Area?
Stai parlando del sassofonista, un po’ problematico, che suonò tra l’altro anche con il gruppo di Kenny Clarke e per un tempo cortissimo con gli Area?
Proprio lui, ma lavorò anche con altre jazz band europee importanti. Busnello, tipo problematico come hai detto, alcolista e dipendente da altre sostanze, nel 1967 viveva in un sottoscala e una sera dopo il nostro spettacolo volle a tutti i costi farmi conoscere un suo amico che suonava nello storico “Swing Club” di Torino, un locale importante, forse quanto il Capolinea di Milano o il Music Inn di Roma. Appena entrammo nel club fui rapito dal fraseggio del sassofonista, sembrava Coltrane! Quel sassofonista durante una pausa venne al nostro tavolo e, parlando un po’ spagnolo e un po’ italiano, mi disse che non aveva un soldo in tasca e non sapeva dove sbattere la testa. Senza pensarci su gli risposi: «In orchestra siamo in sette e se vuoi vieni a suonare con noi e dividiamo per otto». Era Gato Barbieri. Così per quattro mesi l’argentino fece coppia con Eddie Busnello. E una situazione molto simile mi capitò anche a Riccione aiutando nientemeno che Paul Bley, che lavorò con me tutta la stagione estiva suonando rock’n’roll divinamente. Dirai che sono fatti minori, certo, ma che andrebbero raccontati perché la storia vera si fa anche narrando piccoli eventi nascosti tra le pieghe, però non si fa.
E allora nel limite del possibile, e se ti va, facciamolo adesso. Hai altre storie belle da narrare? E quali sono i tuoi artisti preferiti, a parte Ray Charles, a cui tieni in modo particolare?
Di artisti dovrei citarne moltissimi perché ognuno di loro ha fatto qualcosa di straordinario, ad esempio potrei dirti Stevie Wonder. In generale però era il modus dei vari musicisti che mi affascinava. Un momento che ho vissuto con fortissima emozione è successo una decina di anni fa al Chinese Theatre di Hollywood cantando con la mia band alcuni brani del mio album «Tribute to Ray Charles» davanti a una platea di centinaia di persone tra cui decine di star mondiali del cinema. E poi diciamolo, Georgia on My Mind, What I’d Say, I Can’t Stop Living You non me li cava più nessuno. Un’altra bella soddisfazione l’ho avuta nel 1986 con il sondaggio sui migliori cantanti blues italiani dove Gino Castaldo e altri suoi colleghi dissero che spettava a me quel titolo. Colgo l’occasione per dire che i giornali mi riservarono soltanto tre righe, come se non contasse nulla quel risultato, ma in compenso quando andai a Sanremo mi dedicarono delle pagine intere… e non dico altro. Poc’anzi ho citato degli incontri con i grandi jazzmen americani che suonarono a Bologna. E a proposito di Chet Baker aggiungerei che nonostante avesse un carattere molto chiuso, con noi era molto generoso: gli chiedevo spiegazioni di But Not For Me e lui me la cantava. Poi nella Cantina di via Cesare Battisti ho sentito dei mostri come René Thomas. E di queste vicende vissute ne è un po’ testimone Giampiero Cane.
 Quella cantina è stata anche una palestra per la crescita di nuovi talenti bolognesi ma rispetto al fatto di entrare anche solo come uditore nei meandri del jazz bolognese posso dirti che per un po’ di tempo ho notato una certa chiusura, per non dire snobismo, verso giovani profani non “raccomandati”. E quindi spesso era richiesto uno sponsor altrimenti…
Quella cantina è stata anche una palestra per la crescita di nuovi talenti bolognesi ma rispetto al fatto di entrare anche solo come uditore nei meandri del jazz bolognese posso dirti che per un po’ di tempo ho notato una certa chiusura, per non dire snobismo, verso giovani profani non “raccomandati”. E quindi spesso era richiesto uno sponsor altrimenti…
Per caricare la dose posso dirti che se frequentavi il Bar del Rosso (via Augusto Righi), dove si davano appuntamento di notte i grandi capiorchestra di allora, come Henghel Gualdi (considerato uno dei primi clarinettisti europei), Piergiorgio Farina (violinista strepitoso che somigliava a Jean-Luc Ponty) e altri, ma dimostravi di non capire un cazzo di jazz il cuoco ti dava meno ragù sulla tagliatelle, capisci…
Bella battuta ma confermi la mia impressione. Però senza generalizzare e con rispetto, volevo dire che allora vigeva uno spirito da confraternita elitaria di prescelti, intellettuali, dottori, notai, un mondo poco permeabile. Per non parlare poi delle vivacissime discussioni tra veterani jazzofili e giovani neofiti in occasione di performance di alcuni grandi maestri che avevano smarrito la retta via. Eppoi, visto che ci siamo, diciamola tutta: ancora oggi moltissimi jazzofili e jazzisti felsinei o residenti sotto le Due Torri mostrano una sorta cecità o superbia nei confronti di certe espressioni musicali. E’ raro vederli assistere a concerti che non siano quelli dei soliti noti, o di leggendari del jazz. Stop, oltre non si va, nonostante progetti e artisti formidabili di altri mondi.
Io posso dirti la mia verità: in Cantina ho visto dei grandi maestri, ma non discuto però che tu abbia ragione su certi limiti e pigrizie. Però se ti riferivi al free jazz io ho avuto la fortuna a Milano di vedere un concerto storico: nel primo set Nat King Cole con la big band, e quindi tutto secondo copione; mentre nel secondo set suonò John Coltrane, e fu la prima grande botta di free che io ricordi. E quando Coltrane iniziò a suonare si alzarono in piedi Gianni Basso, Oscar Valdambrini assieme ad altri dandogli del buffone. Questa é storia, e io l’ho vissuta e in un certo senso è una conferma della tua osservazione critica.
Non mi riferivo soltanto al free jazz (ma è passato molto tempo), ma ad artisti che si muovono dentro affluenti che migliorano poi il jazz. Detto questo, il giovane Mingardi approvava quella contestazione globale, di rabbia e radicalizzazione di certa black music, da Archie Shepp a Cecil Taylor, Sun Ra, Art Ensemble of Chicagol tanto per intenderci (e dalle nostre parti qualche improvvisato jazzista ci marciava un po’ su, a mio avviso), o stava dalla parte del vecchio jazz rassicurante?
 Poiché sono anche un artista e appassionato di pittura, vedo molte correlazioni tra queste due arti e personalmento ero e sono affascinato dalla ricerca. A volte mi affascinava la ricerca di Luigi Nono, di Stockausen, gente che aveva una spinta un più, toccavano confini ai quali io non riuscivo ad arrivare però mi sforzavo di capire. Alcune opere le capivo, delle altre no, ma le accettavo come un percorso verso qualcosa di diverso. Se tu guardi il primo Picasso, che disegnava in modo sublime, e poi vedi le ultime opere, deliranti, gli domandi: «Ma cosa ti è successo?». Invece bisogna avere la capacità di capire che ci sono delle persone più avanti di noi che hanno visto delle traiettorie e degli orizzonti affascinanti. Orizzonti che forse noi non siamo in grado di vedere. Insomma, le avanguardie hanno sempre creato divisioni. Mi facevano poi ridere, d’altro canto, una schiera di critici musicali quando sostenevano che Oscar Peterson aveva troppa tecnica e avrebbe dovuto essere più concettuale. Io comunque non ho chiuso la porta in faccia a nessuno e la tua sottile osservazione la condivido quando dici che c’erano degli pseudo jazzisti che sfruttavano l’incomprensibilità di certi fenomeni.
Poiché sono anche un artista e appassionato di pittura, vedo molte correlazioni tra queste due arti e personalmento ero e sono affascinato dalla ricerca. A volte mi affascinava la ricerca di Luigi Nono, di Stockausen, gente che aveva una spinta un più, toccavano confini ai quali io non riuscivo ad arrivare però mi sforzavo di capire. Alcune opere le capivo, delle altre no, ma le accettavo come un percorso verso qualcosa di diverso. Se tu guardi il primo Picasso, che disegnava in modo sublime, e poi vedi le ultime opere, deliranti, gli domandi: «Ma cosa ti è successo?». Invece bisogna avere la capacità di capire che ci sono delle persone più avanti di noi che hanno visto delle traiettorie e degli orizzonti affascinanti. Orizzonti che forse noi non siamo in grado di vedere. Insomma, le avanguardie hanno sempre creato divisioni. Mi facevano poi ridere, d’altro canto, una schiera di critici musicali quando sostenevano che Oscar Peterson aveva troppa tecnica e avrebbe dovuto essere più concettuale. Io comunque non ho chiuso la porta in faccia a nessuno e la tua sottile osservazione la condivido quando dici che c’erano degli pseudo jazzisti che sfruttavano l’incomprensibilità di certi fenomeni.
A questo punto cerchiamo invece di rendere comprensibili i tuoi ultimi passi artistici. Intanto con il tuo ultimo album, «Ho visto cose che… » pubblicato nel 2018, hai gridato a tempo che ci vuole un po’ di rock’n’roll «per tutto il popolo dormiente e per svegliare un po’ la mente, dondolando solamente». Cioè?
In questo disco ho raccolto musica concreta, quella che mi appassiona da tutta la vita e ho voluto dare una scossa elettrica a questo mondo di canzoni tutte uguali che circolano in radio e nelle tv. E l’ho fatto con il rock, il blues e altre sonorità black come il soul, sonorità che invece i mass media hanno buttato via come un anziano, come generi musicali superati che non contano più nulla, e che invece contano nella mia storia e nella storia della musica moderna. Mi sono poi voltato indietro, ho guardato all’oggi e alla fine ho cercato di pensare come potrebbe essere il domani di questa società sempre più allo sbando, di giovani che non trovano lavoro. Insomma una realtà che ha perso un bel po’ di valori durante questa folle corsa verso la modernità a tutti i costi e con il risultato di produrre ansia e frustrazione. Per me è una velocità senza senso che sta spazzando via tutto e allora prima che sia tardi diamoci una mossa.
 Intanto vedo che la mossa la dai tu, perché dopo sessant’anni di musica frenetica, di concerti nel tuo stile, svolti un po’ ma sempre on the road per dare nuova linfa alla tua storia rileggendo gli standard vocali del jazz con «E Allora Jazz… ». Parliamone.
Intanto vedo che la mossa la dai tu, perché dopo sessant’anni di musica frenetica, di concerti nel tuo stile, svolti un po’ ma sempre on the road per dare nuova linfa alla tua storia rileggendo gli standard vocali del jazz con «E Allora Jazz… ». Parliamone.
Si tratta di un progetto con intenti rigorosamente jazzistici, affiancato da jazzisti a tutto tondo, che ho voluto dedicare ai grandi classici del Great American Songbook. Sentivo il bisogno di una nuova dichiarazione di amore alla musica afroamericana jazzata e alle immortali interpretazioni di Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Tony Bennet spinto anche dal desiderio di riproporre la cultura musicale che rese Bologna «Capitale del jazz» per vent’anni e non solo in Italia. La storia del jazz in città ha origini lontane, qui sono nate importanti jazz band cittadine che poi fecero tourné anche in Europa. Ma Bologna fu tappa obbligata per i nomi più celebri del jazz come Duke Ellington, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Monk eccetera. E questo lo dobbiamo ad Alberto Alberti e a «Cicci» Foresti, che sono stati gli artefici dello sviluppo della musica jazz sotto le Due Torri.
E proprio con le Due Torri alle spalle hai tenuto un concerto in occasione dell’importante riconoscimento che hai ricevuto: il Premio Strada del Jazz 2019. Cosa ha significato questo premio, credo inatteso e la giornata per la scopertura della stella di Gerry Mulligan?
Sono rimasto sorpreso per questo premio perché nella mia carriera ho suonato soprattutto soul, blues, rock e canzoni anche se lo spirito jazz ha spesso albergato nelle mie musiche come dicevo all’inizio. Sono onorato di questo riconoscimento che premia la mia anima soul e i miei primi passi musicali che vibravano di jazz negli anni Cinquanta e Sessanta. La stella a Mulligan era doverosa. Al di là del premio sono comunque contento che a Bologna abbia ripreso vigore il jazz con tante iniziative prestigiose come quella della Strada del Jazz e il nuovo Bologna Jazz Festival, perché il jazz dà carica e fa star bene. Ma devono stare bene anche i jazzisti?
Qual è il messaggio che non capisco?
Mi riferisco al fatto che ci sono dei gestori di locali che telefonano alla mattina a dei musicisti, anche ad alcuni di quelli bravi e non dei pivellini, proponendogli di andare a suonare un’ora per trenta euro. E questo non va assolutamente bene e capisco chi abbandona poi la musica come mestiere perché questa è umiliazione.
Intervista di Gian Franco Grilli (pubblicata su Musicajazz.it, che ringraziamo)
Foto di Euriolo Puglisi (eccetto quella di apertura e la prima di Gian Franco Grilli)





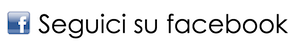






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.